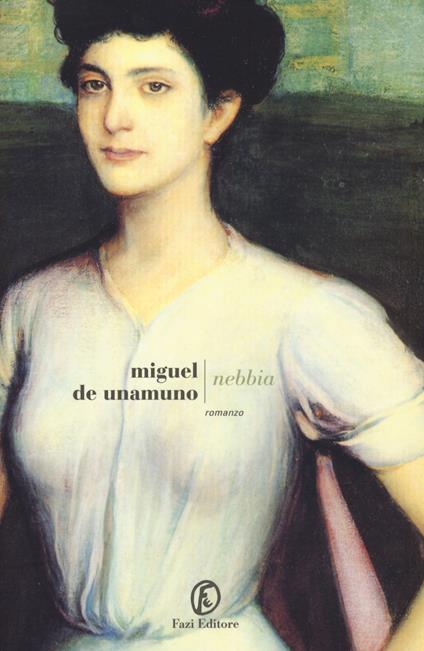Introduzione
Dante ha superato l’inferno e, d’ora in poi, tutto sarà meno arduo perché lui ora è capace di guardare in faccia le sue colpe: ha visto cosa riduce il peccato. Davanti a lui c’è un’intera montagna: è il purgatorio: un luogo di riparazione riservato solo chi si è sinceramente pentito dei propri peccati (veniali) prima di morire, ma non è stato sufficientemente buono da eliminare la tendenza a peccare. Non è un merito da poco quello di Dante: per questo si può dire che egli abbia “inventato” la visione moderna del purgatorio.
La pena peggiore che subiscono tutti coloro
che vanno in purgatorio e il differimento della possibilità di vedere Dio: i
beati, infatti, vedono Dio subito dopo la morte, i purganti no. I purgandi
subiscono anche delle pene “corporali”, nel senso che, pur essendo ombre
incorporee, per volontà di Dio mantengono una sensibilità per poter subire la
sua vendetta. Ma i purgandi non sono solo puniti, bensì anche purificati: sia
assistendo a esempi di condotta edificanti (scolpiti nella roccia, recitati da
voci o veduti in momenti di estasi), sia confessando i propri peccati, sia
bevendo l’acqua dei ruscelli dell’Eden.
Sulla
spiaggia dell’antipurgatorio, Dante alcune anime spaesate scendere da un
vascello velocissimo, guidato da un angelo. Per loro, morte da poco, è
impossibile non essere attratte da Dante, uomo in carne e ossa, il cui corpo,
al contrario del loro, proietta l’ombra. Tutte le anime del purgatorio saranno
colpite dalla corporeità di Dante. Esse sono appena giunte in purgatorio dalla
foce del Tevere e sono ancora impastate di sensazioni e affetti umani. E subito
tra loro, Dante e Virgilio si stabilisce la fiducia, senza nemmeno conoscersi,
perché il purgatorio non c’è posto per la diffidenza.
Dante
si commuove ritrovando un amico, il musico Casella. Ma questa atmosfera
idilliaca è rotta da Catone: dovere ingrato eppure necessario quello del
guardiano dell’antipurgatorio (a suo tempo pagano e suicida per la libertà, è simbolo della libertà e della rettitudine
morale), perché la strada verso l’espiazione definitiva delle proprie colpe non
può patire indugi.
Dante
deve pulirsi la faccia, eliminare ogni scoria dell’inferno: così potrà
proseguire il suo cammino e addentrarsi tra le rupi dell’antipurgatorio che,
oltre che a essere il primo approdo di tutte le anime purganti, ospita coloro
che, pur pentitisi prima di morire, furono troppo peccatori per andare
direttamente in purgatorio e devono scontare un periodo supplementare di
attesa, secondo quanto stabilito da Dio: gli scomunicati (che in vita
furono allontanati dalla Chiesa: anche per loro c’è speranza) e i negligenti
“per forza morti” che trascurarono i doveri religiosi e si pentirono proprio
all’ultimo. Pentirsi costa tanto: significa gettare a mare un’intera vita, un
insieme di ambizioni, speranze, tutte però basate su qualcosa di fragile e
superfluo: i beni materiali.
Come
non ricordare nel canto V Buonconte da Montefeltro, capo ghibellino e perciò nemico
della Chiesa (capo degli aretini sconfitti da Firenze a Campaldino nel 1289,
battaglia alla quale partecipò anche Dante) che, pentitosi proprio all’ultimo,
ora è salvo? E come non pensare al padre di costui, Guido, che invece, pur pentitosi
per tempo, tornò a peccare ed è stato condannato all’inferno (canto XXVII della
prima cantica)?
La
porta del purgatorio (canto IX)
Nel canto IX, trasportato durante il sonno da santa Lucia, santa a cui Dante era devoto, il nostro si ritrova vicino alla porta del purgatorio presidiata da un angelo dotato di spada; la porta infernale era invece enorme e sempre spalancata, coronata da parole che toglievano ogni speranza: accade così perché pochi si salvano e molti preferiscono vivere da disumani e morire nel peccato.
Davanti alla porta ci sono
tre gradini, simbolo dei momenti del sacramento della confessione: Dante li
percorre colmo di umiltà e devozione. Sebbene l’angelo, ministro di Dio,
conosca già le colpe di Dante, il poeta deve ugualmente rivelarle tutte perché
la confessione, per essere efficace, deve giungere spontaneamente dalla bocca
del peccatore. Poi l’angelo apre la porticina grazie a due chiavi, una d’ora e
l’altra d’argento, consegnatigli da san Pietro. Infine, l’angelo traccia sette
“P” sulla fronte di Dante: sono simboli dei sette vizi capitali espiati nei
sette gironi del purgatorio: solo quando tutte e sette le “P” saranno
cancellate, Dante sarà pienamente purificato e potrà accedere al paradiso terrestre.
Gironi I-III: l’amore
diretto al male del prossimo (canti X-XVII)
Entrato in purgatorio, Dante
non si volta perché l’angelo portinaio gli ha intimato di non farlo: chi ha
iniziato a percorrere la strada della redenzione, non può voltarsi indietro né
fermarsi, perché vanificherebbe tutto. E s’accorge che la roccia di quei primi
tornanti del purgatorio è addobbata con stupende sculture, opera di Dio, che
riportano scene di umiltà e atti di superbia punita.
Sì, questa è un’altra idea
geniale di Dante: Dio non fa espiare le colpe solo con le punizioni, ma con gli
esempi, perché al dolore va accompagnato l’insegnamento. Queste scene sono riservate
ai primi peccatori che Dante incontrerà: i superbi. Costretti a portare grossi
massi e a tenere il capo basso, essi subiscono la pena di non poter più
sollevare il capo nella maniera sfrontata con cui lo facevano in vita. Dante li
compatisce perché sa bene che la superbia può nascere in chi esercita l’arte. E
l’incontro con il miniatore Oderisi nel canto XI gli farà capire quanto è
effimera la gloria artistica, quanto sia breve e quanto sia facile che un
artista (come accadde a Cimabue con Giotto) venga presto oscurato da un artista
che arriva dopo di lui. Questo è un saggio insegnamento per Dante, che teme di
dover scontare alcuni anni in purgatorio per la colpa della superbia… ma… se
ancora oggi parliamo di lui e di Giotto forse significa che la gloria artistica
non è sempre poi tanto effimera.
Di certo Dante non temeva di essere giudicato invidioso, almeno a quanto
dice lui, visto che nel canto XIII si confessa lontano da questo peccato da lui
giudicato, già nell’inferno, un vizio tipico nelle corti del suo tempo. Cioè lo
vedeva connesso alla politica e lo giudicava molto grave, vista anche la pena
degli invidiosi.
“Invidiare”, secondo
l’etimologia, significa guardare storto; per questo le anime di chi espia
questo peccato hanno le palpebre cucite con il filo di ferro. Pena assai dura,
degna forse più dell’inferno, segno che essi in vita usarono male il dono della
vista: anziché ammirare la bellezza del creato, usarono gli occhi per odiare e
per sperare di appropriarsi di ciò che apparteneva ad altri. Essi peccarono
quindi doppiamente, sia invidiando, sia desiderando i beni materiali, i quali hanno
il difetto di non bastare mai per tutti e di suscitare, per questo, le più
terribili passioni. Altra cosa sono i beni celesti, che non finiscono mai,
bastano per tutti e, anzi, più uomini ne godono, più essi diventano ricchi.
Parlando degli altri peccatori, gli iracondi, si comprende che per Dante la rabbia non è sempre sbagliata. Costoro hanno voluto il male del prossimo poiché non hanno saputo resistere alle offese e si sono abbandonati a una rabbia malvagia e ingiusta e per questo sono accecati dal fumo nero, perché la rabbia incontrollata acceca. La cosa interessante è che, grazie nell’incontro con l’anima di un iracondo, Marco Lombardo (canto XVI), sorta di alter-ego del poeta si spiega perché la società del tempo sia così malvagia e abbia dimenticato le virtù cristiane. Dante viveva infatti in una società piena di violenza, dove la vita dell’individuo non valeva nulla; una società rovinata da conflitti politici aspri tra le singole città e anche all’interno delle città stesse, in una penisola dove non esisteva un’autorità sovracittadina in grado di garantire sicurezza alle persone.
Questo era il grande cruccio
del poeta. Egli aveva fatto politica attiva a Firenze alla fine del ‘200, durante
le lotte tra la borghesia mercantile e l’aristocrazia, tra i guelfi neri
filo-papali e guelfi bianchi, a cui Dante, con il suo atteggiamento moderato,
era affine. Egli nel 1300 ricoprì anche la carica più importante, quella dei
sei priori, ma dopo la vittoria dei guelfi neri (favoriti da papa Bonifacio
VIII) del 1301, In quanto guelfo bianco, fu esiliato e condannato a morte e
dovette vagare per diverse città e borghi italiani, mendicando pane e denaro.
Ma perché l’uomo commette il male? Dio, infatti, gli ha donato tutte le facoltà per vivere bene seguendo le sue leggi. L’uomo è una creatura imperfetta. Egli sbaglia sia per ragioni “psicologiche”, sia per cause “esterne”, imputabili all’ordine sociale. Dante afferma che l’anima dell’uomo, appena creata da Dio, contiene alcune conoscenze di base (il principio di identità e quello di non contraddizione) e l’inclinazione ad amare Dio. Se l’uomo seguisse questa inclinazione, non peccherebbe mai.
Per
Dante l’uomo possiede il libero arbitrio: Dante aveva il “problema” di
conciliare l’onnipotenza di Dio, con il fatto che esiste il peccato. Se l’uomo
non fosse libero, bisognerebbe ammettere che egli è responsabile di tutto,
anche del male. Ma sarebbe un’eresia. Il possesso della libertà distingue l’uomo
dagli altri animali ma, paradossalmente, rende più facile per lui cadere nel
peccato. In campo conoscitivo, commette degli errori perché esercita le sue
facoltà intellettuali sono limitate e vengono usate male, in campo etico egli cade
nel peccato perché desidera le cose sbagliate.
L’uomo pecca quando fa un
uso distorto dei doni più preziosi che Dio gli ha fatto: la ragione e la libera
volontà.
Egli sbaglia solo per colpa sua: Dio gli donato tutte le facoltà per operare il
bene, ma l’uomo, l’unica creatura dotata di libertà, può scegliere il male. L’uomo
non è un burattino, ma è libero e, proprio in quanto tale, responsabile agli
occhi di Dio delle sue azioni. per questo può essere dannato o salvato.
Il fatto che l’uomo sia
libero fonda la sua responsabilità, non solo nei confronti di Dio, ma anche
sulla terra, nei confronti degli altri uomini. Essere liberi significa seguire
le leggi di Dio e le leggi (giuste) della società civile. Se non esistesse il
libero arbitrio dell’uomo, non avrebbe senso la struttura dei regni dell’aldilà
che Dante immaginato e diverrebbe vano il compito che egli si è attribuito,
quello di far ravvedere gli uomini raccontando loro come i peccatori sono puniti
o salvati. Se la salvezza dell’uomo è in buona misura opera della grazia di Dio
che agisce per motivi imperscrutabili, l’individuo può fare qualcosa per
meritarsi tale grazia ossia operare il bene.
L’uomo è, come diceva Aristotele, un “animale” sociale destinato a vivere in società retta da leggi. Se dal punto di vista “psicologico”, Dio ha donato a l’uomo l’inclinazione ad amare i beni celesti, da quello esteriore, per rendere felice l’uomo, Dio ha stabilito l’esistenza di due autorità politiche, l’imperatore e il papa, entrambe incaricate di guidare l’individuo verso la felicità. Quella terrena grazie all’imperatore, quella celeste grazie al papa. Dio anche in questo caso aveva fatto le cose per bene, stabilendo che l’impero debba occuparsi delle leggi civili, mentre al papa spetti il compito di far osservare all’individuo le leggi di Dio.
Il problema è che ormai da
lungo tempo nessuno fa rispettare le leggi civili e, di conseguenza, nessuno fa
più rispettare la parola di Dio. Gli imperatori tedeschi (l’impero ormai è
quello…), infatti, non guardano più all’Italia; dall’altro lato, gli uomini di
Chiesa non si occupano più dell’anima delle persone ma sono da secoli
interessati alle ricchezze materiali e al potere politico, tanto è vero che, al
tempo di Dante, la Chiesa possiede già molti territori nell’Italia centrale, al
tempo chiamati “Patrimonio di San Pietro”. Per questo Date pensa che la colpa
maggiore per la decadenza della società italiana sia da attribuire al papa,
perché il potere politico è stato donato all’impero (prima Romano e poi
tedesco) da Dio; l’imperatore, dunque, ha ricevuto il potere politico in
“concessione” e non può alienarlo, non può trasferirlo a un’altra autorità (al
papa), perché tale potere appartiene solo a Dio. Per questo Dante ritiene
illegittimo il documento su cui la Chiesa basava il suo diritto a esercitare il
potete temporale, la (oggi sappiamo che era un falso) donazione di Costantino.
Dante è molto duro contro gli uomini di Chiesa, tanto che mette all’inferno
tutti i papi a lui contemporanei.
L’idea che potesse tornare un impreso universale era anacronistica, perché già da tempo era in atto il processo che avrebbe condotto alla formazione degli stati nazionali, come Francia e Inghilterra. Dante aveva però intuito che l’Italia, rimanendo ai margini della politica europea a causa degli egoismi particolari, sarebbe stata condannata a restare divisa per molto tempo. Attenzione, Dante non aveva in mente l’unità d’Italia e dunque non era un anticipatore di quel che avvenne nel 1861, però deplorava lo spirito di fazione che angustiava la vita di tante città italiane. Lui aveva capito che tale frammentazione tra le città italiane, che si riverberava anche sulla frammentazione linguistica, sarebbe stato un fattore di debolezza politica nel futuro e difatti così fu. Con la nascita degli stati nazionali, l’Italia sarà oggetto della spartizione tra di loro e per lunghi secoli rimarrà un paese debole, frammentato e litigioso.
L’ordinamento
del purgatorio (canto XVII)
Alla fine dei primi tre gironi del purgatorio, i pellegrini fanno una sosta. Virgilio ne approfitta per spiegare a Dante qual è l’ordinamento del purgatorio. La cosa più “sconvolgente” è leggere che tutti i nostri atti, anche quelli peccaminosi, nascono dall’amore. Dunque, non sempre l’amore è buono, perché il suo valore dipende dall’oggetto amato. Si è detto che l’uomo è libero e che nasce con una innata tendenza a desiderare: senza desiderio, non potremmo vivere, perché gran parte della vita si struttura attorno alla brama di raggiungere qualcosa, sin da piccoli. Eppure, se tale tendenza a desiderare sceglie gli oggetti sbagliati, ecco il vizio e il peccato.
Accanto a un amore
naturalmente diretto verso Dio, la sola cosa che dovremmo amare veramente,
esiste un amore di “elezione”, nel quale si esercita la scelta dell’uomo, che può
errare se desidera “il malo obietto”. Gli oggetti malvagi possono essere tanti
e talvolta apparire anche molto attraenti, ma sono tali per l’uomo ingenuo o
incapace di usare la ragione. Per Dante si tratta dei beni materiali: il sesso,
la gloria, il denaro, il potere, il cibo: essi sono mali in sé, ma lo diventano
se perseguiti con ossessione. La foga dei beni materiali è all’origine di tutti
i mali del mondo: poiché tali beni sono fragili e non sono sufficienti per
tutti, essi suscitano gelosie, invidia, rabbia e superbia.
Il superbo, l’invidioso e
l’iracondo desiderano il male del prossimo e abbiamo già visto come scontano
questo loro amore malato; se invece l’uomo agisce in virtù di un amore troppo
tiepido verso Dio, cade nel vizio dell’accidia (punito nel quarto girone);
quando invece l’uomo brama senza misura i beni mondani (cibo, sesso, denaro),
conduce a commettere i peccati di avarizia, gola e lussuria, puniti negli
ultimi tre gironi del purgatorio.
Ma ci si può pentire proprio
di tutti i peccati e finire in purgatorio? Per Dante sembra di no: solo le colpe di
incontinenza possono essere espiate, non quelle dovute alla malizia e alla
violenza, peccati mortali che destinano irrimediabilmente all’inferno, dal VII
cerchio in giù.
Per Dante il fine dell’uomo
è la vita secondo ragione, ossia la capacità di evitare gli eccessi esercitando
la virtù della temperanza, individuando il giusto mezzo da due comportamenti
estremi ugualmente peccaminosi. Si prenda la superbia: è normale che un uomo
abbia stima di sé; tuttavia, quando tale stima diventa eccessiva ed egli si
sente superiore a tutti gli altri, commette peccato (dunque commetterebbe
peccato anche chi, al contrario, ha un’autostima troppa bassa, ma Dante non ne
parla). Quando l’individuo non è capace di trovare tale equilibrio, si hanno le
colpe di incontinenza.
Gli
ultimi tre cerchi (canti XIX-XXVI)
Leggendo dell’incontro con i
peccatori del quinto cerchio, gli avari e i prodighi, mi ha stupito l’omaggio a
Virgilio e la lode a poeti “pagani”, capaci però di intuire, senza esserne
consapevoli, alcune verità cristiane.
Tra coloro che hanno le mani
bucate Dante e Virgilio incontrano l’anima del poeta latino Stazio. Costui
esprime grande ammirazione verso Virgilio arrivando addirittura ad affermare
che la sua conversione al cristianesimo nacque leggendo i versi delle Bucoliche in cui Virgilio parla
dell’arrivo di un fanciullo grazie al quale giungerà (anzi, tornerà) l’età
dell’oro. Questi versi erano stati visti sin dai primi cristiani come un
preannuncio dell’avvento di Cristo, come a voler rimarcare che ogni momento
della storia dell’uomo faccia parte di un piano provvidenziali stabilito da
Dio.
Dante inventa di sana pianta
la vicenda della conversione del poeta latino Stazio al cristianesimo, per
esaltare Virgilio nel momento in cui si sta avvicinando l’addio alla sua guida:
il poeta latino, ahimè, non conobbe il cristianesimo e, dunque, non poté
salvarsi, rimanendo confinato nel limbo.
Pur con tutto il bene che
gli voleva, Dante non avrebbe potuto presentare un Virgilio salvato perché le
sue parole sarebbero state ai limiti dell’eresia. Ma Virgilio, se non è stato
cristiano, ha avuto il merito per Dante di aver intuito la fede, illuminando la
strada a chi è venuto dopo di lui: “Per te poeta fui, per te cristiano” (v.
73). Queste parole, nella finzione narrativa pronunciate da Stazio,
rispecchiano in pieno il pensiero di Dante.
Ora, si può storcere il naso
sul fatto che il cristiano Dante si faccia guidare nell’aldilà dal pagano
Virgilio. Ma la Commedia non è solo un poema sacro, bensì anche una
grande opera di poesia. La poesia non ha limiti di tempo, di patria, né soffre
barriere religiose: essa racconta l’indicibile, l’indescrivibile ed è il mezzo
migliore per parlare di qualcosa che nessuno (o quasi) può vedere in vita, i
regni dell’aldilà. Esiste insomma una sorta di universo poetico a cui
appartengono tutti i grandi poeti antichi perché per Dante costoro, pur
ignorando l’avvento di Cristo, nei loro versi mostrano di aver intuito qualcosa
e di averlo scritto, certo sotto forma di favole o con un linguaggio poco
chiaro. Senza tali poeti, senza le loro intuizioni, senza i loro versi che
fanno lumeggiare una verità più alta, non esisterebbe la società cristiana e
Dante non troverebbe le parole per raccontare del suo viaggio nell’aldilà.
Nel canto XXIII, tra i
golosi, orrendamente emaciati e suppliziati come Tantalo (vedono una sorgente
d’acqua fresca e un albero pieno di frutti invitanti ma, appena si avvicinano
ad essi per assaggiarli, entrambi scompaiono), Dante incontro l’anima di Forese
Donati, suo amico di gioventù, ha l’occasione
di dialogare con lui. Forese era morto nel 1296 ed era fratello di Corso
Donati, capo dei guelfi neri fiorentini nemici di Dante.
L’incontro con Forese è
interessante per due motivi; uno, ci fa capire che anche nell’aldilà posso
permanere affetti umani. La cosa non è molto ortodossa, ma risponde all’umanità
della poesia di Dante, alla grandezza del suo cuore e al fatto che egli ha
scritto la Commedia anche per rivedere i suoi
amici. Due, è un modo che Dante impiega per scusarsi di un passato giovanile
dissoluto. Il poeta, richiamando il momento della sua vita in cui, assieme a
Forese, visse una fase di traviamento morale, dice: “Se tu riduci a mente /
qual fosti meco e qual io teco fui, / ancor fia grave il memorar presente”
(vv. 115-117). A cosa si riferisce Dante? Forse a quel periodo in cui a Firenze
era esplosa una moda che aveva infiammato i giovani, quella dei duelli poetici.
Tra Forese e Dante in gioventù c’era stato uno scambio di sonetti senza peli
sulla lingua. Per esempio, a Dante che scrive all’amico accusandolo di non
“scaldare” a sufficienza la moglie, Forese risponde con dei versi un po’
oscuri, i quali avanzano il sospetto che suo padre Alighiero avesse praticato
l’usura.
Secondo l’Ottimo commento del
1333, Dante era al corrente della golosità dell’amico e sarebbe stato proprio
lui a indurlo a pentirsi in punto di morte. Nella “tenzone” poetica tra i due,
ci sono alcuni versi del nostro che alludono alla golosità dell’amico. Una di
queste poesie, presa dall’edizione delle Rime di Dante curata da De Robertis, recita: “Ben ti
faranno il nodo Salamone, / Bicci novello, e petti delle starne, / ma peggio
fia la lonza del castrone, / ché ‘l cuoio farà vendetta della carne”. Dante
dice che il suo amico Bicci (soprannome di Forese) sarà presto incastrato dal
cappio (nodo) di Salomone (che non si poteva sciogliere), poiché il petto delle
starne e la carne di castrato, lo ridurranno in miseria. Il peccato dei golosi
è esecrato non solo per i danni morali, ma anche per quelli economici.
Dante pensava che avrebbe
incontrato l’amico nell’antipurgatorio, non già in purgatorio pochi anni dopo
essere morto. Forese spiega a Dante che il periodo che lui avrebbe dovuto
passare nell’antipurgatorio è stato abbreviato dalle preghiere di sua moglie
Nella; costei, la sua “vedovella”, è una donna buona e onesta, essendo tra le
poche donne virtuose rimaste a Firenze. L’omaggio a Forese e la sottolineatura
della moralità di sua moglie Nella, sono un risarcimento di Dante nei confronti
della reputazione della donna alla quale nei suoi versi giovanili aveva rivolto
delle frasi poco rispettose.
I lussuriosi e l’amore
Primi peccatori incontrati
nell’inferno e ultimi peccatori del purgatorio (ma anche dell’intera Commedia), i lussuriosi sono immersi nel
fuoco, simbolo della loro passione. Tra i lussuriosi che saranno salvato ci
sono anche quelli “contro natura”, cioè gli omosessuali, che però nella Commedia
sono definiti ermafroditi. Se per Dante l’amore sregolato è il peccato, tale
non è un amore vissuto con misura. In ciò egli è coerente con buona parte della
trattatistica moralistica del tempo che era raramente sessuofobica e tendeva a
essere comprensiva verso una sessualità vissuta con ragionevolezza.
Ma non è solo per questo che
Dante dona centralità all’amore. Egli è stato un poeta d’amore che ha innovato
la lirica erotica creando quello che lui stesso, nel canto XXIV, definisce
“dolce stil novo” (in realtà lo nomina l’anima del poeta lucchese Bonagiunta).
Oltre a uno stile dolce e soave, il poeta d’amore è colui che scrive sotto
dettatura di questo grande sentimento, che Dante conosce sin da giovanissimo,
quando s’innamora di Beatrice.
Dante ha il merito di non concepire
l’amore in modo drammatico o distruttivo (come il suo maestro Guido
Guinizzelli, incontrato nel canto XXVI o Guittone), come una forza che può
portare anche alla morte. Dante vuole anzi nobilitare l’amore affermando che,
se esso è diretto vero una donna nobile e onesta, può condurre l’uomo alla
beatitudine, come accadrà a lui grazie a Beatrice (da qui il nome Beatrice). Certo,
anche l’amore verso una donna con tratti celestiali è sconvolgente e
appassionante: Dante era consapevole della forza sovrabbondante del desiderio e
da grande intellettuale qual era ha accettato questa forza, non l’ha denigrata,
ma ha cercato di nobilitarla.
Nella
Commedia questa concezione dell’amore viene ulteriormente sviluppata poiché
si trasforma: da sentimento terreno, diventa caritas, ardore di carità,
amore verso Dio; nondimeno, sebbene esso abbia un carattere celeste, non è meno
forte dell’amore che si prova sulla terra verso qualcuno: anche l’amore verso
Dio non perdona che chi è amato non riami a sua volta, anche tale amore si
accende nell’animo del fedele come un fuoco incontrollabile, anche l’amore
verso Dio sconvolge l’anima.
Queste
espressioni richiamano i celebri versi del canto V dell’Inferno: la
colpa della sventurata Francesca era aver definito il suo amore adultero con
gli stessi caratteri di irresistibilità e forza che ha l’amore verso Dio.
Francesca lo faceva per difendersi, affermando di non aver saputo resistere;
Dante la compiange perché in parte la capisce, ma soprattutto perché la donna
non aveva saputo superare il carattere sensuale del sentimento e si era fatta
del tutto ghermire da lui, amando un uomo, Paolo, che non avrebbe dovuto amare
essendo suo cognato. Se ella si fosse pentita, non sarebbe finita all’inferno,
bensì in purgatorio e si sarebbe salvata.
Diversa
la vicenda di un’altra donna Pia dei Malavolti,
la cui anima Dante incontra nel canto V del Purgatorio. Anche lei fu
uccisa dal marito, ma non per adulterio, bensì perché l’uomo, Nello d’Inghiramo
dei Pannocchieschi, voleva sposare un’altra donna. Pia ormai non prova odio,
perché è salva e preferisce ricordare la felicità provata il giorno delle nozze
anziché il giorno della morte.
Il
compito dell’amore terreno è quello di preparare l’uomo alla beatitudine. E ciò
può accadere solo se si ama una creatura dotata di quelle qualità definita dal
verso iniziale di un altro sonetto della Vita nuova: Tanto gentile e
tanto onesta pare. La donna amata deve essere gentile (ossia di animo
nobile), onesta (decorosa nell’aspetto e nel vestire).
Dante nell’Eden (canti XXVII-XXXIII)
Dopo i lussuriosi, Dante attraversa, grazie a Virgilio e assieme a Stazio, la barriera di fuoco che Dio (cfr. la Genesi) ha posto tra il purgatorio e il paradiso terrestre. Una volta nell’Eden, Dante è abbandonato da Virgilio: il poeta latino rappresenta la ragione umana, la quale non può guidare l’uomo verso Dio. D’altra parte, Dante ha visitato tutto l’inferno e tutto il purgatorio: gli sono state cancellate le sette “P” dalla fronte e, dunque, come dice Virgilio, egli è ormai padrone di sé stesso.
Guidato
da Matelda, una donna bella e misteriosa, Dante si gode il paesaggio
meraviglioso dell’Eden finché… be’, finché non appare Beatrice. E allora si può
fare un po’ di gossip sulla vita di Dante. Nel libro III della Vita nuova, l’opera scritta in gioventù in cui
racconta il suo amore per lei, Dante narra che egli rivede Beatrice a diciotto
anni, nove anni dopo averla incontrata la prima volta da bambino. Ebbene,
quando Dante rivede Beatrice, lui è ancora uno sbarbatello, lei invece, pur
giovane, è una donna sposata e probabilmente ha già dei figli. In quel momento,
accade un fatto straordinario: Beatrice, che cammina assieme a due donne più
anziane ed è vestita con una veste bianca, simbolo di purezza, lo saluta. Il
nostro tocca allora il cielo con un dito; anzi, come dice lui con maggiore
finezza: “me parve allora vedere tutti li termini della beatitudine” (par. 1).
Dopo
di ciò, Dante corre nella sua cameretta, s’addormenta e sogna. Vede Amore che
gli dice che da quel momento in poi lui sarà il suo Signore. Amore tiene fra le
braccia Beatrice: ella è nuda, ha una veste colore del sangue; su indicazione
di Amore, “la donna de la salute”, mangia il cuore del poeta. Beatrice lo
mangia con timidezza e, dopo averlo fatto, non è più lieta ma piangente. Amore
la tiene fra le sue braccia e sparisce verso il cielo.
Nel Purgatorio, canto XXX, sorgendo da sotto un carro trainato da un grifone, simbolo
della Chiesa, Dante vede salire una miriade di angeli festanti che circondano
una figura femminile che scende dal cielo con un velo che le copre parte del
volto e il capo. La donna indossa un mantello verde e una vesta del colore
della fiamma: si tratta di Beatrice, che è ora una creatura del cielo. Dante reagisce
come un uomo innamorato, perché è ancora un individuo in carne ed ossa ed è
cotto di Beatrice sin da quando aveva nove anni. Se era innamorato della
Beatrice umana, figuriamoci se non lo è della Beatrice creatura celeste.
Nell’Eden il
nostro, ben prima di vedere Beatrice, va in panico e vive le medesime
sensazioni che ebbe in gioventù quando fu invitato da un amico in un luogo dove
erano adunate molte persone. A un certo punto il nostro poeta, che se ne stava
bello tranquillo, avverte uno sconvolgimento totale perché, pur non avendola
ancora vista, “sente” che Beatrice è presente nella casa. Prima ancora di
vedere la donna amata, lui va in panico (Vita
nuova, XIV.4).
La stessa cosa
accade alle soglie del paradiso ed è bello questo parallelo tra biografia del
poeta e vicenda narrata nella Commedia.
Nel canto XXX lui scrive che, presentendo la presenza di Beatrice nell’Eden: “E lo spirito mio … / d’antico amor sentì la
gran potenza” (vv. 34-39) e poi ai vv. 46-48 rivolto a Virgilio per
chiedere aiuto (che nel frattempo è sparito): “conosco i segni del’antica fiamma”. Ancora oggi noi usiamo la parola
“fiamma” per indicare un partner.
Beatrice non
appare a Dante per dargli il benvenuto, bensì per bastonarlo. Lui ha appena
salutato definitivamente Virgilio e piange perché il suo amato Virgilio e se ne
va. Ma Beatrice gli dice che sono ben altre le cose per cui dovrebbe piangere
perché Beatrice è molto arrabbiata con lui. E lo chiama per nome, “Dante” al v.
55, è l'unica volta nella Commedia appare il nome del poeta perché,
quando ci si confessa è necessario enunciare il proprio nome. E qui si inscena
un vero e proprio processo a Dante. Beatrice è davvero molto rigorosa, come una
mamma arrabbiata col figlio.
L’accusa
principale che lei muove al poeta è quella di averla dimenticata: una volta che
lei è morta, lui ha smesso di seguire la strada che lei gli indicava, la via
verso la beatitudine, e si è dato ad altro tanto da cadere nel peccato e da
ritrovarsi nella famosa selva. Dante viene colpito moltissimo da questi
rimproveri che lui accetta come un figlio colpevole, ma piange, sviene, non
riesce a parlare. Addirittura, a un certo punto, gli angeli dicono a Beatrice:
perché lo strapazzi tanto? E lei ribatte: voi siete abituati a guardare Dio per
l’eternità e siete senza peccato, ma lui ha bisogno di essere strapazzato,
perché deve confessare le sue colpe con la sua voce. Perché è ovvio che
Beatrice, che è una donna del cielo, conosce già le colpe di Dante. Dio conosce
le colpe dell'uomo, ma solo se l'uomo le confessa autonomamente, può essere
perdonato. Questo esame di
coscienza lo dovrebbe fare ogni uomo che legge la Commedia
per riconoscere i propri errori e redimersi. Dante scrive per tutti noi, non
solo per lui stesso, e vuole prendersi carico delle nostre colpe. Non bisogna
scordare che nell’Eden, davanti agli angeli, alla processione mistica e a
Beatrice, che è un’inviata del cielo, non c'è solo il Dante uomo, ma c'è
l'intera umanità perché Beatrice è simbolo di Cristo e Dante è simbolo
dell'umanità.
Le colpe di
Dante
Come mai Dante
fa questa sorta di autoanalisi in cui si imputa di aver peccato, in cui fa dire
a Beatrice: “perché tu, che eri nato sotto una congiunzione astrale favorevole
e che avevi ricevuto da Dio enormi talenti, hai sprecato questi talenti per
perseguire attività che non lo meritavano?”. Forse Dante imputava a sé stesso di aver amato altre donne per trovare
sollievo dopo la scomparsa di Beatrice; in effetti, nella Vita nuova lui scrive che dopo la morte della donna egli ha cercato consolazione
presso una donna gentile; però alla fine dell’opera, Dante dichiara di essere
“tornato” ad amare Beatrice e a celebrarla e difatti ha una visione in cui la
vede salire in cielo circondata d'angeli, un po' come l'immagine che abbiamo
qua in purgatorio.
In realtà,
senza stare a lambiccarsi il cervello, si potrebbe tornare alla Vita nuova
per capire di cosa Dante si sentisse colpevole. Alla fine dell’opera, Dante scriveva: “Sì che, se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia
vita duri per alquanti anni, io spero di dicer di lei quello che mai non fue
detto d’alcuna”. Dante alla fine
della Vita nuova promette di scrivere in futuro un’opera per
celebrare adeguatamente Beatrice. Ecco la colpa di Dante, simbolo di
ogni altra colpa: dopo più di quindici anni dalla conclusione della sua opera
giovanile, non aver ancora adempiuto alla promessa solenne di celebrare la
gloria di Beatrice e la Commedia è
proprio l'opera grazie alla quale Dante riesce a mantenere quella promessa.
Una volta confessate
le proprie colpe, Beatrice attribuisce a Dante la missione di raccontare
fedelmente agli altri uomini quel che ha visto il purgatorio. Ora Dante può
accedere ai riti di purificazione: accompagnato da Matelda, beve l'acqua del fiume
Lete che cancella il ricordo delle tendenze peccami. Poi beve l'acqua di un
altro ruscello, l’Eunoè, che restaura
il ricordo delle buone azioni. Dante è tornato puro come quando era nato: la
purificazione dell'anima che si appresta ad andare in paradiso è una seconda
nascita. Dante adesso è quindi pronto a salire in paradiso: “puro e disposto
a salire ale stelle” (canto XXXIII).